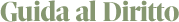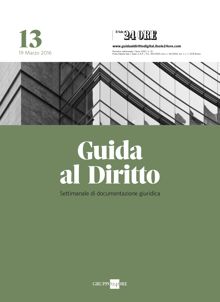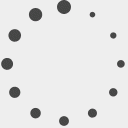Esasperare lo scontro tra avvocati e Antitrust non giova al sistema
IL TEMA DELLA SETTIMANA Il conflitto in atto tra avvocatura e autorità antitrust «non giova a nessuno». Ne sono convinti i professori Marcello Clarich e Giuliano Fonderico, per i quali solo «un approccio meno ideologico potrebbe aiutare a confezionare risposte istituzionali alle sfide della modernità che investono inevitabilmente anche il mondo delle libere professioni. Diritto ed economia devono e possono dialogare. Ma ciò richiede un rinnovamento culturale dell'avvocatura».