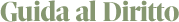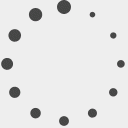Decreto sicurezza, un concetto pigliatutto poco mirato sui diritti
IL TEMA DELLA SETTIMANA Le novità principali contenute nel decreto legge 14/2017 sulla sicurezza urbana si fermano alle intenzioni. Secondo il professore Roberto Cornelli gli enti locali non sono chiamati ad affrontare concretamente problemi di convivenza o di conflittualità sull’uso degli spazi, di degrado, di esclusione sociale e di marginalità. Nel decreto Minniti l'orizzonte dell’intervento dei sindaci è definito da approcci, da strumenti e da finalità che vincolano il Comune ad agire nel solco di quel diritto amministrativo punitivo prefigurato dai pacchetti sicurezza Maroni: le ordinanze infatti sono strumenti poco appropriati per garantire la sicurezza dei diritti di tutti.