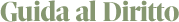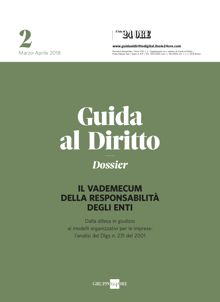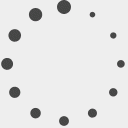Un agile strumento contro il “caos” dell’interpretazione
IL TEMA DELLA SETTIMANA Il nuovo reato di autoriciclaggio (legge 186/2014), le determinazioni dell’Autorità anticorruzione del 2015, le novelle in tema di appalti (Dlgs 50/2016) e il documento elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del giugno 2016 costituiscono gli ultimi approdi cui conformare i sistemi 231 che la Guida esamina nei tratti peculiari.